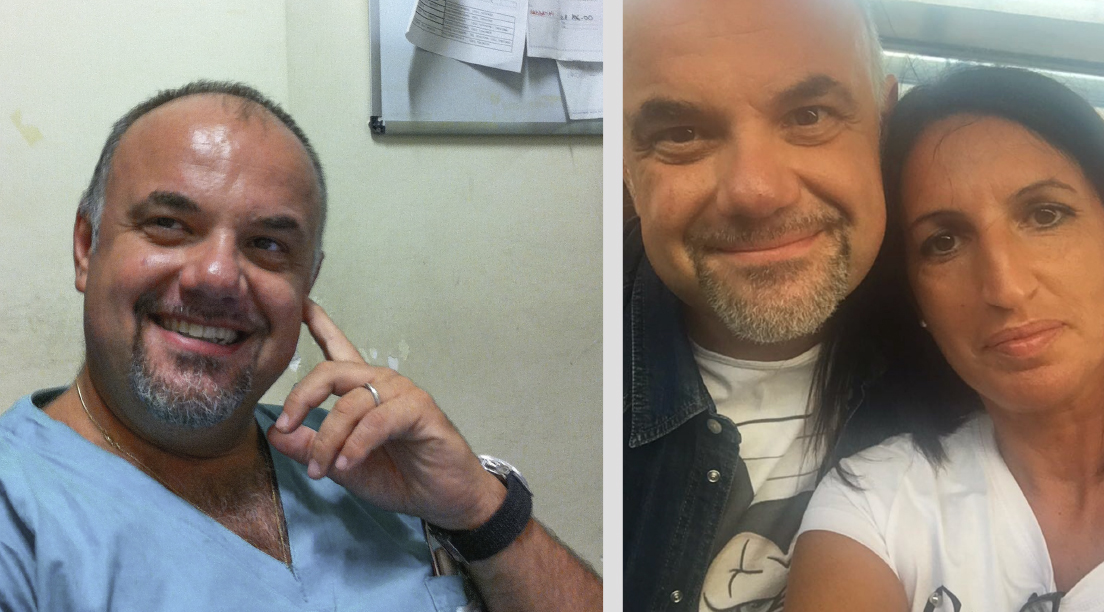Michele Ilari, Medico Chirurgo
Specialista in Chiurgia Pediatrica
Incarico di Alta Specializzazione in Chirugia Oncologia Pediatrica
Ospedale Materno Infantile "G. Salesi"
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
"È NECESSARIO PREMETTERE CHE…"
così cominciava la presentazione della mia tesi di laurea il 31 Marzo 1995, discussa presso l’aula Valdoni dell’ Università "La Sapienza" di Roma ed “E’ necessario premettere che…” è molto difficile conoscere completamente se stessi, perché si possa dire comprensibilmente “questo sono io”!...
Quel giorno, ancora “nevoso”, mi accompagnò come Relatore di tesi, il Professor Carlo Marcelletti, un uomo molto particolare, formatosi anche lui con "niente" e dal "niente" e che era arrivato ad essere nominato il Responsabile della Cardiochirurgia pediatrica in un Ospedale ad Amsterdam, l’Academisch Medisch Centrum prima, e poi, per "volere" di Papa Giovanni Paolo II, il Responsabile della Cardiochirurgia e Trapianto di cuore pediatrici dell’ Ospedale Bambino Gesù di Roma contribuendo a far diventare il reparto negli anni "a venire", un’eccellenza di livello mondiale.
Quell’evento mi segnò ovviamente non solo dal punto di vista "professionale", ma anche e molto dal punto di vista "umano", perché Carlo Marcelletti era una persona con un carisma molto "forte" che si muoveva dall’ Ospedale, per venire ad assistermi al "conseguimento" della Laurea in Medicina.
In quel mio "primo" percorso "romano", mio cugino Ciano e sua moglie Anna Maria mi aiutarono molto, e a loro dovrò sempre riconoscenza assoluta, pur non frequentandoli purtroppo “più”.
Mio padre Alfonso invece, era morto qualche tempo prima e non era riuscito a "vedere" nemmeno a quale Università mi fossi iscritto.
Ho avuto la fortuna di convivere con mio papà, pochissimo, purtroppo! Anche lui era un uomo "carismatico", severo e con un profondo senso della famiglia e dello Stato; fu costretto, durante la II guerra mondiale, dopo la firma dell’Armistizio, in un campo di concentramento nella attuale Russia Orientale, periodo del quale non parlava mai e che lo "faceva" piangere ogni qualvolta ascoltasse l’inno nazionale Italiano anche solo prima di una partita di calcio.
Mi ha insegnato il rispetto per gli altri e per le cose, anche e soprattutto quelle "pubbliche", la correttezza dei comportamenti e l’attaccamento indiscusso alla famiglia, il senso di appartenenza e come valutare e considerare le persone "vicine" e con cui si collabori.
Mi rimane un grande rispetto, soprattutto del suo "ricordo"; non riesco a descriverne la sensazione, ma si tratta di un sentimento che mi costringe in ogni mio comportamento e ne definisce le caratteristiche.
Il giorno della mia Laurea, fu la prima e l’ultima "cosa" che conobbe invece mia madre della mia carriera di medico, perché morì anche lei qualche anno dopo durante i miei primi anni di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica…
Mia mamma Giuseppina, ha svolto un ruolo fondamentale nella mia formazione di uomo e di Medico: donna “forte”, energica, a volte intransigente, ma sempre umile ed altruista; bastava che chiunque la “vedesse” e ci parlasse anche e soltanto una sola volta, sembrava che la conoscesse da una vita intera.
Dopo la morte di mio padre, si è, senza grossa difficoltà comunque, “rimboccata le maniche” ed ha cominciato ad organizzare quanto di meglio possibile, perché io e mia sorella non ne subissimo un “contraccolpo” maggiore oltre a quello emotivo già fin troppo devastante!.
Non posso non ricordare, gli sforzi che abbia fatto negli anni, anche solo perché “quadrassero i conti”; all’inizio, per qualche tempo, trovò lavoro come “aiuto cuoca” presso un ristorante di Ripatransone sulla strada che da Grottammare vicino San Benedetto “porta” a Montalto delle Marche, che si trovava vicino ad una discoteca e che quindi “lavorava” molto di più a cena.
La notte tardi, anzi intorno alle 2:00 di mattina, con mia sorella Arianna che dormiva nel sedile posteriore, andavo a riprenderla alla fine del turno, con le mani che Le facevano male e che non riusciva a muovere per diverse ore; una volta arrivati a casa, con la scusa di dovermi rimborsare la benzina, mi regalava le 50.000 lire che aveva appena guadagnato.
I ricordi che comprendano mia madre sono tantissimi, e “restano” in gran parte solo “i miei”; uno su tutti e purtroppo l’ultimo, però, è quello di appena cinque giorni prima di morire: uscimmo insieme a “fare la spesa" e “capitammo” al mercato, presso la bancarella di una azienda vitivinicola della zona, che aveva ancora in vendita delle bottiglie di vino “novello”, mi avvicinai per comprarne un paio per un piccolo “pensiero” per Francesco e per Denis, due miei Colleghi di Roma dove frequentavo la Scuola di Specializzazione; mi fermò e mi rimproverò chiedendomi che significato avesse presentare un regalo con una sola bottiglia di vino; prese 20.000 lire dal portafoglio (era il 26 del mese e quelle 20.000 “pesavano” tantissimo!) ed acquistammo 2 confezioni da 2 bottiglie di vino “novello” ciascuna che il giorno dopo, solerte, consegnai.
I giorni, immediatamente successivi alla morte di mamma, sono stati allucinanti: per tre giorni e tre notti sono rimasto a letto alzandomi solo per mangiare; alla fine del terzo giorno alcuni dei miei più cari amici d’infanzia: Daniele, Sirio, Enrico e Massimo con l’aiuto di Arianna e Anna (Colei che sarebbe poi diventata mia moglie!) mi alzarono “a forza” dal letto, mi sistemarono e mi costrinsero a stare con loro.
Tornai a Roma solo dopo un po' di tempo con un entusiasmo ridotto al minimo, ma con la consapevolezza che, anche e soltanto per il ricordo delle persone che non c’erano più, avrei dovuto terminare la Scuola di Specializzazione.
Il Direttore della Scuola era il Professor Francesco Cozzi (detto Franco), uomo severo nei modi, ma con una bontà d’animo ed una educazione nei comportamenti, di riscontro sempre più raro. Parlava molto con noi specializzandi, è questo era sempre un “bene”, perché in quelle poche volte in cui ti accorgevi che non aveva voglia di discutere, era spesso perché gli dispiaceva “riprenderti” per qualcosa che avevi fatto di “scorretto”.
Nel corso degli anni, ti rendevi conto che Franco Cozzi era uno di famiglia, sarebbe potuto essere senza problemi, tuo fratello maggiore o tuo padre, del quale non ti saresti voluto perdere la più piccola parola o la minima espressione, perché sicuramente ti avrebbero insegnato a parlare meglio o a come comportarti.
Un giorno, dopo una delle mie “diverse” disavventure umane, oltre a quelle già capitatemi, e per la quale avrei voluto abbandonare la Scuola di Specializzazione e forse il mestiere del Medico per sempre, mi prese in disparte, chiuse le porte della sua stanza (ce n’erano due!) e mi disse: “Sai per certo che la Scuola di Specializzazione potrebbe ed andrà certamente “avanti” anche senza di te…ma se fossi stato mio figlio, ad una proposta del genere ti avrei preso a calci nel … (…omissis…)!”
Le sue parole mi colpirono molto, anche perché nemmeno lui credo, sapesse, se avessero fatto o meno “breccia” nel mio animo “compromesso”; ma invece ebbero un effetto deflagrante, soprattutto perché quando certe espressioni vengano utilizzate da una persona che tu ritenga anche solo “idonea” a “proportele”, risuonano devastanti.
I suoi allievi, in parte sono rimasti a Roma (per esempio Denis, il figlio del Professor Cozzi continua a dirigere il reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Università “Sapienza”) in parte nel resto d’Italia e alcuni in giro per il mondo; ognuno con “qualcosa” che gli abbia lasciato in ricordo Franco Cozzi, che a tutt’oggi continua a studiare alacremente e a proporre novità per migliorare le cure in ambito pediatrico.
Roma, ha segnato pressochè in tutto, la mia vita: con Francesco, con cui dividevo spesso il tempo in Ospedale e in pizzeria (!), un giorno scendemmo di alcuni piani, dalla Chirurgia all’OncoEmatologia della Palazzina Pediatrica del Policlinico Universitario per controllare un paziente che avevamo pochi giorni prima operato ed incontrammo Anna (conosciuta alcuni mesi prima!) alla quale chiesi il perché non mi avesse ancora invitato a mangiare quella pizza “promessa”. La risposta fu ovviamente sorpresa, e Anna appunto, mi disse a quale cena mi riferissi perché non la ricordava minimamente (non sarebbe potuto essere altrimenti perché si trattava di una situazione del tutto inventata!). “Chicco Morini” (così tutt’ora chiamiamo Francesco!) con la velocità di interpretazione felina, che ancora oggi lo contraddistingue, prese la “palla al balzo” e disse a tutti e due che anche lui aveva sentito con chiarezza della promessa. A quel punto Anna si trovò in difficoltà e fu pressochè costretta ad invitarmi.
Si sente spesso dire, di come la fortuna, possa essere “correlata” alla possibilità di trovarsi nel “posto giusto” al “momento giusto” e con la “persona giusta”; ed esattamente “quella” fu la sensazione di quando iniziò il mio “rapporto” con Anna; ad un età ormai adulta e “avanzata”, è certo di come, riuscire a conoscere una persona che ti possa “moralmente” completare e con la quale condividere più anni ed esperienze possibili della tua vita, non sia facile, anzi che sia spesso praticamente impossibile.
A quel punto, quindi, Anna mi invitò a cena e decidemmo che saremmo andati a mangiare in una pizzeria di viale Regina Margherita e che “apparteneva” ad una catena di ristoranti: “Napoletano’s”, che adesso credo non esista più. Si trattava di un “evento” così importante e “conosciuto”, che chiunque condividesse con me quel periodo “romano”, era prodigo di consigli che riteneva “adeguati”; Alessandra una mia Collega di specializzazione, mi consigliò, che una volta arrivato sotto casa di Anna, sarei dovuto scendere dalla macchina, una Ford KA color “carta da zucchero” metallizzato, ed aprirle lo sportello in segno di cortesia e rispetto; ovviamente mi dimenticai di ciò che mi era stato detto, anzi, se più “maldestri” si possa essere, feci in tempo a scendere dalla macchina, ma non ad aprire lo sportello (!).
Il problema però, era stato un altro: il giorno della cena era “intorno” al 20 del mese; mancavano cioè circa 10 giorni all’accreditamento dello stipendio in banca. A quel tempo, poi, non si trattava di uno stipendio vero e proprio, ma di una borsa di studio di veramente pochi soldi: 800.000 lire al mese; quando per l’affitto della mia stanza in via Giovanni da Procida 31 ne pagavo 500.000 (!). Mia mamma e mia sorella Arianna ancora mi aiutavano, ma i miei risparmi quel giorno erano purtroppo finiti. Il mio orgoglio di “maschio”, non mi avrebbe, infatti, mai “permesso” di non pagare la cena: avevo 5.000 lire nel portafoglio, ma ero comunque tranquillo perché avevo con me la carta di credito, che ancora oggi permette l’addebito della spesa, nel mese successivo al prelievo. Mi recai per essere sicuro del “successo” e nel primo pomeriggio, presso il bancomat di una filiale della mia banca, inserii la carta di credito, ma con mio sgomento, fu immediatamente “risucchiata” dalla macchina, senza che avessi più la possibilità di recuperarla (era venerdì!). Il lunedì successivo, in banca, mi dissero che avevo esaurito la disponibilità di prelievo anche del mese successivo e quindi il “freddo” bancomat, era stato “costretto” a ritirarla.
Che cosa avrei potuto fare quindi a quel punto; la scusa di una improvvisa influenza non reggeva, tantomeno quella che immediatamente sarei dovuto tornare la sera stessa a San Benedetto da mia madre (!).
Ero veramente triste e sfiduciato! Decisi allora con qualche piccola difficoltà “ideale”, di chiedere aiuto a Francesco, con la promessa che la fine del mese in corso, gli avrei restituito i soldi eventualmente prestati. Senza nessun problema, Francesco mi consegnò 50.000 lire che mi sarebbero dovute bastare però per la benzina, per le pizze e le “bevande” (!). Per tutta la sera pensai, tra le altre “cose”, a che tale disfatta sarebbe stata se non mi fossero bastati poi i soldi per la cena, ma con l’estrema abilità che mi è propria nella gestione del “patrimonio” disponibile, riuscii nell’intento prefissato, Anna non si accorse di nulla, e la serata risultò fantastica.
CONTINUA…
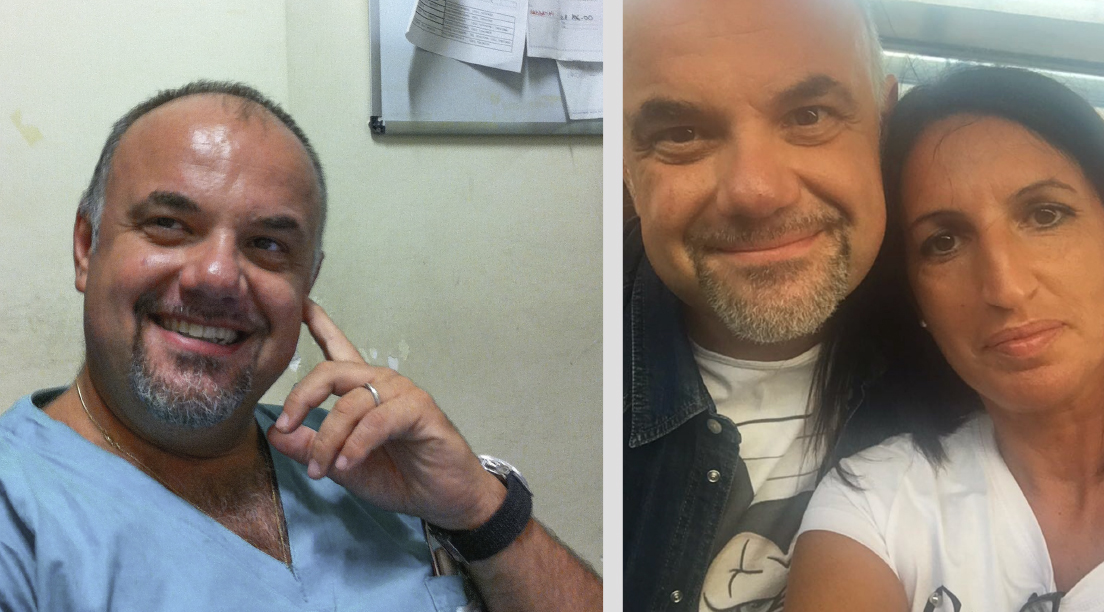
Michele Ilari, Medico Chirurgo
Specialista in Chiurgia Pediatrica
Incarico di Alta Specializzazione in Chirugia Oncologia Pediatrica
Ospedale Materno Infantile "G. Salesi"
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
"È NECESSARIO PREMETTERE CHE…"
così cominciava la presentazione della mia tesi di laurea il 31 Marzo 1995, discussa presso l’aula Valdoni dell’ Università "La Sapienza" di Roma ed “E’ necessario premettere che…” è molto difficile conoscere completamente se stessi, perché si possa dire comprensibilmente “questo sono io”!...
Quel giorno, ancora “nevoso”, mi accompagnò come Relatore di tesi, il Professor Carlo Marcelletti, un uomo molto particolare, formatosi anche lui con "niente" e dal "niente" e che era arrivato ad essere nominato il Responsabile della Cardiochirurgia pediatrica in un Ospedale ad Amsterdam, l’Academisch Medisch Centrum prima, e poi, per "volere" di Papa Giovanni Paolo II, il Responsabile della Cardiochirurgia e Trapianto di cuore pediatrici dell’ Ospedale Bambino Gesù di Roma contribuendo a far diventare il reparto negli anni "a venire", un’eccellenza di livello mondiale.
Quell’evento mi segnò ovviamente non solo dal punto di vista "professionale", ma anche e molto dal punto di vista "umano", perché Carlo Marcelletti era una persona con un carisma molto "forte" che si muoveva dall’ Ospedale, per venire ad assistermi al "conseguimento" della Laurea in Medicina.
In quel mio "primo" percorso "romano", mio cugino Ciano e sua moglie Anna Maria mi aiutarono molto, e a loro dovrò sempre riconoscenza assoluta, pur non frequentandoli purtroppo “più”.
Mio padre Alfonso invece, era morto qualche tempo prima e non era riuscito a "vedere" nemmeno a quale Università mi fossi iscritto.
Ho avuto la fortuna di convivere con mio papà, pochissimo, purtroppo! Anche lui era un uomo "carismatico", severo e con un profondo senso della famiglia e dello Stato; fu costretto, durante la II guerra mondiale, dopo la firma dell’Armistizio, in un campo di concentramento nella attuale Russia Orientale, periodo del quale non parlava mai e che lo "faceva" piangere ogni qualvolta ascoltasse l’inno nazionale Italiano anche solo prima di una partita di calcio.
Mi ha insegnato il rispetto per gli altri e per le cose, anche e soprattutto quelle "pubbliche", la correttezza dei comportamenti e l’attaccamento indiscusso alla famiglia, il senso di appartenenza e come valutare e considerare le persone "vicine" e con cui si collabori.
Mi rimane un grande rispetto, soprattutto del suo "ricordo"; non riesco a descriverne la sensazione, ma si tratta di un sentimento che mi costringe in ogni mio comportamento e ne definisce le caratteristiche.
Il giorno della mia Laurea, fu la prima e l’ultima "cosa" che conobbe invece mia madre della mia carriera di medico, perché morì anche lei qualche anno dopo durante i miei primi anni di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica…
Mia mamma Giuseppina, ha svolto un ruolo fondamentale nella mia formazione di uomo e di Medico: donna “forte”, energica, a volte intransigente, ma sempre umile ed altruista; bastava che chiunque la “vedesse” e ci parlasse anche e soltanto una sola volta, sembrava che la conoscesse da una vita intera.
Dopo la morte di mio padre, si è, senza grossa difficoltà comunque, “rimboccata le maniche” ed ha cominciato ad organizzare quanto di meglio possibile, perché io e mia sorella non ne subissimo un “contraccolpo” maggiore oltre a quello emotivo già fin troppo devastante!.
Non posso non ricordare, gli sforzi che abbia fatto negli anni, anche solo perché “quadrassero i conti”; all’inizio, per qualche tempo, trovò lavoro come “aiuto cuoca” presso un ristorante di Ripatransone sulla strada che da Grottammare vicino San Benedetto “porta” a Montalto delle Marche, che si trovava vicino ad una discoteca e che quindi “lavorava” molto di più a cena.
La notte tardi, anzi intorno alle 2:00 di mattina, con mia sorella Arianna che dormiva nel sedile posteriore, andavo a riprenderla alla fine del turno, con le mani che Le facevano male e che non riusciva a muovere per diverse ore; una volta arrivati a casa, con la scusa di dovermi rimborsare la benzina, mi regalava le 50.000 lire che aveva appena guadagnato.
I ricordi che comprendano mia madre sono tantissimi, e “restano” in gran parte solo “i miei”; uno su tutti e purtroppo l’ultimo, però, è quello di appena cinque giorni prima di morire: uscimmo insieme a “fare la spesa" e “capitammo” al mercato, presso la bancarella di una azienda vitivinicola della zona, che aveva ancora in vendita delle bottiglie di vino “novello”, mi avvicinai per comprarne un paio per un piccolo “pensiero” per Francesco e per Denis, due miei Colleghi di Roma dove frequentavo la Scuola di Specializzazione; mi fermò e mi rimproverò chiedendomi che significato avesse presentare un regalo con una sola bottiglia di vino; prese 20.000 lire dal portafoglio (era il 26 del mese e quelle 20.000 “pesavano” tantissimo!) ed acquistammo 2 confezioni da 2 bottiglie di vino “novello” ciascuna che il giorno dopo, solerte, consegnai.
I giorni, immediatamente successivi alla morte di mamma, sono stati allucinanti: per tre giorni e tre notti sono rimasto a letto alzandomi solo per mangiare; alla fine del terzo giorno alcuni dei miei più cari amici d’infanzia: Daniele, Sirio, Enrico e Massimo con l’aiuto di Arianna e Anna (Colei che sarebbe poi diventata mia moglie!) mi alzarono “a forza” dal letto, mi sistemarono e mi costrinsero a stare con loro.
Tornai a Roma solo dopo un po' di tempo con un entusiasmo ridotto al minimo, ma con la consapevolezza che, anche e soltanto per il ricordo delle persone che non c’erano più, avrei dovuto terminare la Scuola di Specializzazione.
Il Direttore della Scuola era il Professor Francesco Cozzi (detto Franco), uomo severo nei modi, ma con una bontà d’animo ed una educazione nei comportamenti, di riscontro sempre più raro. Parlava molto con noi specializzandi, è questo era sempre un “bene”, perché in quelle poche volte in cui ti accorgevi che non aveva voglia di discutere, era spesso perché gli dispiaceva “riprenderti” per qualcosa che avevi fatto di “scorretto”.
Nel corso degli anni, ti rendevi conto che Franco Cozzi era uno di famiglia, sarebbe potuto essere senza problemi, tuo fratello maggiore o tuo padre, del quale non ti saresti voluto perdere la più piccola parola o la minima espressione, perché sicuramente ti avrebbero insegnato a parlare meglio o a come comportarti.
Un giorno, dopo una delle mie “diverse” disavventure umane, oltre a quelle già capitatemi, e per la quale avrei voluto abbandonare la Scuola di Specializzazione e forse il mestiere del Medico per sempre, mi prese in disparte, chiuse le porte della sua stanza (ce n’erano due!) e mi disse: “Sai per certo che la Scuola di Specializzazione potrebbe ed andrà certamente “avanti” anche senza di te…ma se fossi stato mio figlio, ad una proposta del genere ti avrei preso a calci nel … (…omissis…)!”
Le sue parole mi colpirono molto, anche perché nemmeno lui credo, sapesse, se avessero fatto o meno “breccia” nel mio animo “compromesso”; ma invece ebbero un effetto deflagrante, soprattutto perché quando certe espressioni vengano utilizzate da una persona che tu ritenga anche solo “idonea” a “proportele”, risuonano devastanti.
I suoi allievi, in parte sono rimasti a Roma (per esempio Denis, il figlio del Professor Cozzi continua a dirigere il reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Università “Sapienza”) in parte nel resto d’Italia e alcuni in giro per il mondo; ognuno con “qualcosa” che gli abbia lasciato in ricordo Franco Cozzi, che a tutt’oggi continua a studiare alacremente e a proporre novità per migliorare le cure in ambito pediatrico.
Roma, ha segnato pressochè in tutto, la mia vita: con Francesco, con cui dividevo spesso il tempo in Ospedale e in pizzeria (!), un giorno scendemmo di alcuni piani, dalla Chirurgia all’OncoEmatologia della Palazzina Pediatrica del Policlinico Universitario per controllare un paziente che avevamo pochi giorni prima operato ed incontrammo Anna (conosciuta alcuni mesi prima!) alla quale chiesi il perché non mi avesse ancora invitato a mangiare quella pizza “promessa”. La risposta fu ovviamente sorpresa, e Anna appunto, mi disse a quale cena mi riferissi perché non la ricordava minimamente (non sarebbe potuto essere altrimenti perché si trattava di una situazione del tutto inventata!). “Chicco Morini” (così tutt’ora chiamiamo Francesco!) con la velocità di interpretazione felina, che ancora oggi lo contraddistingue, prese la “palla al balzo” e disse a tutti e due che anche lui aveva sentito con chiarezza della promessa. A quel punto Anna si trovò in difficoltà e fu pressochè costretta ad invitarmi.
Si sente spesso dire, di come la fortuna, possa essere “correlata” alla possibilità di trovarsi nel “posto giusto” al “momento giusto” e con la “persona giusta”; ed esattamente “quella” fu la sensazione di quando iniziò il mio “rapporto” con Anna; ad un età ormai adulta e “avanzata”, è certo di come, riuscire a conoscere una persona che ti possa “moralmente” completare e con la quale condividere più anni ed esperienze possibili della tua vita, non sia facile, anzi che sia spesso praticamente impossibile.
A quel punto, quindi, Anna mi invitò a cena e decidemmo che saremmo andati a mangiare in una pizzeria di viale Regina Margherita e che “apparteneva” ad una catena di ristoranti: “Napoletano’s”, che adesso credo non esista più. Si trattava di un “evento” così importante e “conosciuto”, che chiunque condividesse con me quel periodo “romano”, era prodigo di consigli che riteneva “adeguati”; Alessandra una mia Collega di specializzazione, mi consigliò, che una volta arrivato sotto casa di Anna, sarei dovuto scendere dalla macchina, una Ford KA color “carta da zucchero” metallizzato, ed aprirle lo sportello in segno di cortesia e rispetto; ovviamente mi dimenticai di ciò che mi era stato detto, anzi, se più “maldestri” si possa essere, feci in tempo a scendere dalla macchina, ma non ad aprire lo sportello (!).
Il problema però, era stato un altro: il giorno della cena era “intorno” al 20 del mese; mancavano cioè circa 10 giorni all’accreditamento dello stipendio in banca. A quel tempo, poi, non si trattava di uno stipendio vero e proprio, ma di una borsa di studio di veramente pochi soldi: 800.000 lire al mese; quando per l’affitto della mia stanza in via Giovanni da Procida 31 ne pagavo 500.000 (!). Mia mamma e mia sorella Arianna ancora mi aiutavano, ma i miei risparmi quel giorno erano purtroppo finiti. Il mio orgoglio di “maschio”, non mi avrebbe, infatti, mai “permesso” di non pagare la cena: avevo 5.000 lire nel portafoglio, ma ero comunque tranquillo perché avevo con me la carta di credito, che ancora oggi permette l’addebito della spesa, nel mese successivo al prelievo. Mi recai per essere sicuro del “successo” e nel primo pomeriggio, presso il bancomat di una filiale della mia banca, inserii la carta di credito, ma con mio sgomento, fu immediatamente “risucchiata” dalla macchina, senza che avessi più la possibilità di recuperarla (era venerdì!). Il lunedì successivo, in banca, mi dissero che avevo esaurito la disponibilità di prelievo anche del mese successivo e quindi il “freddo” bancomat, era stato “costretto” a ritirarla.
Che cosa avrei potuto fare quindi a quel punto; la scusa di una improvvisa influenza non reggeva, tantomeno quella che immediatamente sarei dovuto tornare la sera stessa a San Benedetto da mia madre (!).
Ero veramente triste e sfiduciato! Decisi allora con qualche piccola difficoltà “ideale”, di chiedere aiuto a Francesco, con la promessa che la fine del mese in corso, gli avrei restituito i soldi eventualmente prestati. Senza nessun problema, Francesco mi consegnò 50.000 lire che mi sarebbero dovute bastare però per la benzina, per le pizze e le “bevande” (!). Per tutta la sera pensai, tra le altre “cose”, a che tale disfatta sarebbe stata se non mi fossero bastati poi i soldi per la cena, ma con l’estrema abilità che mi è propria nella gestione del “patrimonio” disponibile, riuscii nell’intento prefissato, Anna non si accorse di nulla, e la serata risultò fantastica.
CONTINUA…